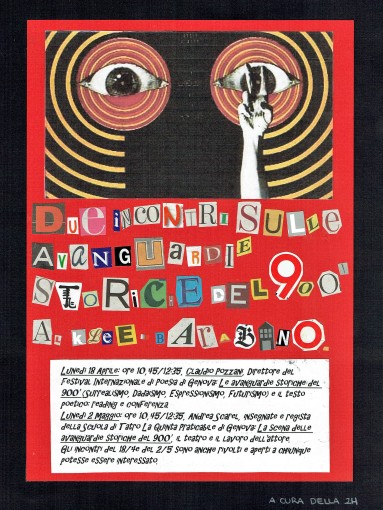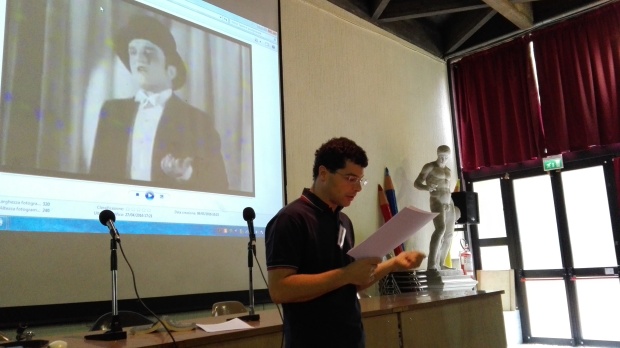L.A.
KLEE-BARABINO
Cl.
2H
LE
AVANGUARDIE STORICHE DEL '900
Simona Cabella
Con il
termine AVANGUARDIE STORICHE si indicano movimenti
artistico-culturali sviluppatisi in Europa dal '900 fino a gli anni
trenta circa; vengono definite cosi per distinguerle dalla
neoavanguardie nate dopo la seconda guerra mondiale.
Le
avanguardie rompono gli schemi artistici tradizionali, sono complesse
e dietro c'è molto studio e molta ricerca. Spesso non vengono
capite, perché viste superficialmente, mentre per comprenderle
bisogna analizzarle a fondo.
Nella
civiltà contemporanea è difficile proporre nuove avanguardie.
La tecnologia si è
rivelata, oltre ad un beneficio, anche un limite e la gente di oggi
ha una mentalità diversa da quella dei primi decenni del 900.
Bearice
D'Antonio
Tra
le avanguardie artistiche quella che sento più vicina ai miei gusti
è l’espressionismo. Amo i colori forti, contrastanti fra loro e
le pennellate cariche di colore che quasi creano dei solchi nella
tela. Mi piacciono i soggetti dell’espressionismo tedesco, ovvero
la gente comune, persino nella scelta di mostrare il lato, per così
dire, brutto delle persone e il fatto che l’arte venisse intesa
come strumento contro la propaganda politica nazista.
L’espressionismo è si un’evoluzione dell’impressionismo, ma
esso non accetta il fatto che la pittura debba essere piacevole alla
vista o debba essere verosimile, con colori tenui e soggetti allegri
e pieni di vita.
Anche
ai giorni nostri, forse con l'uso di caricature, il fare arte contro
la società e la politica è fattibile, globalmente parlando, e
probabilmente farei anch’io dei quadri di questo genere; però
dipingerei solo la società italiana, corrotta e decadente. Sì, mi
piacerebbe farlo, e forse lo farò se ne avrò l’occasione, ma
mischierei il colore del gruppo Fauves e i soggetti del gruppo Die
Bruche.
L’espressionismo
è espressione dell’artista in tutti i campi artistici: l’artista
deve essere libero di fare arte ma può arrivare al punto in cui
rappresenta una minaccia per la società e per il potere. Difatti in
Germania, nel periodo nazista, ad alcuni artisti fu impedito il
continuare a produrre la loro arte e altri furono obbligati ad
emigrare negli Stati Uniti. Anche oggi si possono ripresentare questi
problemi, ma comunque in Italia non molti hanno fatto qualcosa di
concreto. Comunque credo che nel nostro paese difficilmente potrà
avvenire una rivoluzione di tipo avanguardistico, perché le
avanguardie, fondamentalmente, sono contro i modelli tradizionali e
il nostro è un paese prevalentemente tradizionalista.
Sara
Ferrari
Nel
ventunesimo secolo ormai non si avverte più l'influenza delle
avanguardie storiche, gli importanti movimenti artistici che
caratterizzarono i primi decenni del ‘900 e che produssero idee e
proteste contro la società borghese che deteneva il potere in quel
periodo.
Infatti con
l’avanzare degli anni, la classe borghese ha riacquistato il potere
che prima, in parte, era stato messo in crisi.
Oltretutto
i metodi per divulgare le notizie e la cultura sono cambiati e queste
vengono manipolate secondo gli interessi dei governi.
Riproporre
un modello di protesta simile a quello delle avanguardie dei primi
decenni del '900 sarebbe praticamente impossibile nei nostri tempi.
Il
progresso portato dalle nuove tecnologie ha fatto in modo di imporre,
oltre ad una idealizzazione della società dei consumi, anche dei
canoni che dobbiamo seguire per permetterci di vivere
tranquillamente.
Per
far si che tutti si limitino a vivere senza idee proprie e sotto
l’influenza delle multinazionali, è necessario, infatti,
“insegnare”, fin dai primi giorni di vita, alle persone ad
uniformarsi e a opporsi ad ogni tipo di innovazione che andrebbe
contro i canoni preimposti dalla società, escludendo tutte quelle
persone con idee diverse dal “comune”.
Quindi
divulgare un pensiero rivoluzionario verrebbe considerato da molti
come minaccia e verrebbe impedito immediatamente.
Ormai
le persone non sono più abituate a pensare e hanno bisogno di un
modello da seguire.
Forse
potrebbe essere più efficace creare un movimento di pensiero guidato
in anonimato sia da adulti che da giovani che creino arte seguendo
modelli ispirati all’impressionismo.
Infatti
può essere molto efficace creare arte sulla base di soggetti, anche
astratti, e immagini che rimandano emozioni, piuttosto che in base a
testi o manifesti scritti, soprattutto perché, per quanto possa
garantirci il governo che ogni uomo è libero di pensare e scrivere
quello che più gli aggrada, ogni testo, se viene ritenuto
pericoloso, verrà facilmente censurato.
Benché
le avanguardie presentino stili diversi come il dadaismo e il
surrealismo, secondo me per rendere un movimento artistico efficace
bisognerebbe seguire appunto le idee dell’impressionismo.
Esso
infatti, derivando dal romanticismo, è un movimento caratterizzato
dai sentimenti; considerando che le persone ormai hanno una mentalità
chiusa per quanto riguarda formulare dei pensieri diversi
dall’ordinario, esse tendono a reagire a ogni modello che trasmetta
emozioni e sensazioni forti.
Per
arrivare ad una rivoluzione mentale di massa quindi sarebbe forse
meglio iniziare appunto con l’arte rappresentata in modo semplice,
ma che dia all’osservatore emozioni immediate e anche che susciti
un senso di mistero, così da portare l’osservatore a cercare una
vera spiegazione all’opera in un modo che lo induca a guardare
dentro se stesso.
Così,
oltre ad attirare l’attenzione e suscitare emozioni, questo
movimento potrebbe diventare un nuovo punto di riferimento e far sì
che la società si rivolti contro il potere oppressivo per diventare
una comunità di persone coi propri pensieri.
Federica
Marinelli
Se i
concetti che sono stati alla base delle avanguardie storiche fossero
riproposti nella civiltà di oggi, secondo me non avrebbero un grande
impatto. La società dei nostri giorni, per la maggior parte, ha
imparato ad assorbire tutto ciò che è alternativo e che va contro a
qualcosa. Nel campo dell'arte ormai più nulla è considerato
“strano”, ma allo stesso tempo le persone non sanno soffermarsi
sull'analisi e sul significato dei particolari. Come succedeva anche
nel novecento, spesso le persone non sanno o non vogliono andare
oltre alle apparenze, non raggiungono il nocciolo e si fermano a ciò
che si nota al primo impatto.
Le
avanguardie storiche invece chiedono un lavoro di concentrazione per
essere comprese.
Anche
nel contesto contemporaneo le avanguardie vengono capite solo da
gruppi ristretti, mentre il resto della società si sofferma alle
apparenze, magari inizialmente le critica, ma alla fine le considera
come tanti altri movimenti e pensieri alternativi che che si
aggiungono alla infinita e indistinta diversità che già esiste.
Tutti i
movimenti, i pensieri, che un tempo venivano criticati, sono stati
assorbiti dalla società e con il passare del tempo avere idee
diverse è diventato quasi una moda.
Dire di
credere in qualcosa per risultare diversi è un modo per venire
accettati e apprezzati ma, come ho già detto prima, spesso ci si
ferma alla superficialità e quindi la maggior parte delle persone
non sa veramente cosa sia ciò in cui dice di credere.
Tra le
avanguardie storiche, due mi hanno interessata in maniera
particolare, il surrealismo ed il dadaismo.
Del
surrealismo mi affascina l'inconscio, il concentrarsi sul sogno e
l'allontanarsi da ciò che è logico. La realtà dei sogni è
complessa, ed è il fatto che si allontani del tutto da spiegazioni
razionali che mi piace.
Nell'arte
dei nostri giorni secondo me il surrealismo potrebbe riproporsi
ancora con successo; quest'arte si sofferma ad analizzare un mondo
complesso e apparentemente irragionevole e questo è l'aspetto più
interessante.
Il
Dadaismo invece è un arte che si concentra sull'umorismo in senso
provocatorio. Il nome viene da “dada” che è un suono che cerca
di ricordare le prime parole di un bambino. Gli artisti dadaisti
prendono in giro in modo umoristico gli altri al di là della logica.
La cosa che più mi colpisce è il significato ed il senso che si
trova dietro ad ogni poesia ed opera d'arte, che a primo impatto
possono sembrare infantili.
Mentre
il surrealismo si concentra sullo studio di concetti complessi, le
opere dadaiste appaiono quasi infantili e secondo me non verrebbero
accettate proprio perché in apparenza appaiono semplici e facili da
farsi per chiunque.
Gabriele
Teodosio
Sicuramente
tra tutte le avanguardie dei primi decenni del '900 quella che mi ha
appassionato di più è il dadaismo. Sono stato attratto da questa
corrente fin da subito.
A
dire il vero ero in cerca di una forma d’arte così irriverente,
satirica e che rifiutasse i preconcetti e quasi li deridesse. Quando
creo qualcosa di mio, con la mia fantasia, mi accorgo che questo
movimento è molto presente dentro me. Opere come “Fontana“ di
Duchamp, geniali e d’impatto, danno una scossa alle persone e le
fanno ragionare; è ovvio che un vespasiano rovesciato non è una
fontana, ma serve per provocare chi in un primo momento avrà un
rifiuto ma, dopo aver riflettuto, probabilmente ne capirà il
messaggio ironico nei confronti del concetto classico di arte. È
proprio questo il nocciolo della questione, il dadaismo fa pensare a
qualcosa che nella società moderna manca e che quindi serve per più
motivi: innanzitutto viviamo in una società frenetica e sempre
veloce, questo ci porta ad essere sempre e costantemente sotto
pressione e a prendere decisioni in fretta senza pensare; inoltre non
essendo più abituati a pensare non sappiamo nemmeno noi cosa ci
piace realmente, anche se nei social networks valutiamo la nostra
vita a seconda del mi piace e del non mi piace. L’arte oggi
potrebbe essere vivificata anche dal dadaismo che risveglierebbe la
creatività nel nostro mondo. Uno dei messaggi del dadaismo è
appunto quello di rompere gli schemi e dove, se non in Italia,
avremmo bisogno di una rivoluzione artistica per far capire che
l’arte in tutti i campi non è solo quella classica? Anche se nata
più di un secolo fa, questa avanguardia può funzionare ancora oggi.

Greta
Zappalà
Avanguardia
è sinonimo di opinione intellettuale, artistica e letteraria.
Gli
artisti dell'avanguardia sono i più estremisti, innovativi...
L'avanguardia
nei primi decenni del '900 si impone come movimento artistico: ne
sono esempi l'espressionismo, l'astrattismo, il futurismo, il
cubismo, il dadaismo e il surrealismo.
Gli
artisti di questi movimenti si proponevano il compito di andare
controcorrente e in modi diversi, di opporsi, provocare, criticare.
Charles
Baudelaire, già nel secolo precedente, potrebbe considerarsi uno dei
precursori delle avanguardie.
L'espressionismo
è il movimento artistico che preferisco in quanto rappresenta una
realtà più profonda, una realtà che viene più dall'animo. E'
un'ondata di creatività e ribellione. In pratica si '' sostituisce
'' l'occhio esterno con quello interno, dello spirito. Questo nuovo
linguaggio è ricco di contenuti sociali e di una realtà drammatica.
La realtà di quegli anni era la guerra. Gli artisti espressionisti,
inoltre, polemizzavano contro la società borghese, l'alienazione del
lavoro... Criticavano anche gli artisti che li avevano preceduti. La
cosa fondamentale, quando si dipingeva, era la comunicazione di un
qualcosa di diverso; era creare un rapporto profondo fra l'artista e
il mondo. Mi piace questo movimento perche' strano, originale.
Secondo me i principi dell'espressionismo potrebbero ancora risultare
scomodi, anche per la società contemporanea. Gli espressionisti
esprimono attraverso l'arte gli stati d'animo e mettono in risalto
le emozioni del pittore, attraverso l'uso dei colori in disarmonia
fra loro in modo da creare nervosismo, violenza. In molti casi, le
figure avevano un significato politico e sociale. Quindi c'è un
rapporto diretto fra scontro politico/sociale e arte. Io credo che
possa essere una buona idea riproporre questi principi. La gente si
scandalizzerebbe, ma sarebbe una spinta per la società, per cambiare
qualcosa, migliorare il mondo in modo alternativo e intelligente.

Garziano
Valeria
L’arte
è uno dei mezzi migliori per esprimere e trasmettere un’idea.
Il
concetto di avanguardia nel campo dell’arte può essere un mezzo
per protestare e per esporre le proprie idee e potrebbe venir
riproposto nella società dei nostri giorni come risposta ai politici
e alle loro concezioni opponendosi agli schemi tradizionali che ci
sono nella società, esprimendosi in modo diretto, stuzzicando
l’attenzione dell’osservatore, ma senza creare maggiore
confusione.
La
nostra società è basata sull’essere abiutuati ad avere sempre una
risposta immediata, sul non cercare cosa sarebbe meglio, ma solo ciò
che è facile da ottenere. Non si è abituati ad esprimere veramente
ciò che si pensa, ma è diffusa una grande superficialità. Perciò
il tipo di avanguardia che dovrebbe riproporsi in questa società
dovrebbe riuscire a scuotere le persone da queste condizioni e, in
modo diretto, dovrebbe mandare un messaggio di ritorno a ciò che è
veramente importante. Il concetto dovrebbe essere appunto diretto, ma
non superficiale o banale, in quanto scopo delle avanguardie è una
ricerca dei significati. Perciò si dovrebbe con forza catturare
l’attenzione di chi osserva, in questo modo l’osservatore sarebbe
attratto e presterebbe molta attenzione, di conseguenza il messaggio
arriverebbe chiaramente.
Tra
le avanguardie artistiche dei primi decenni del ‘900 quella che mi
intaressa di più è il dadaismo. Questo perché si basa molto
sull’ironia , sull’umorismo e, ovviamente, va contro ogni
consueta logica. Quello che mi attrae è il fatto che l’ironia,
invece che risultare una presa in giro, porta farsi delle domande e a
cercare di capire quale ideologia e quale pensiero si nasconde dietro
un’opera. Personalmente, invece che rimanere basita davanti a
un’opera dadaista, che è una reazione comune, rimango affascinata
dalle idee che hanno avuto quegli artisti. Penso che sia affascinante
capire ciò che ha portato alla realizzazione di qualcosa. Questa
avanguardia è quella che stravolge di più il senso comune, in
quanto elimina la logica tradizionale e ne crea una tutta propria.
I
principi dadaisti potrebbero rappresentare un riferimento nella
civiltà odierna siccome ancora adesso ci sono delle forme di arte
che si basano sull’ironia, anche se, secondo me, queste hanno per
lo più lo scopo di prendere in giro o di infastidire, invece che
creare una logica alternativa.
Aaike
Nicols
Le
Avanguardie storiche, nel passare degli anni, sono sempre andate
contro al senso comune o al normale modo di intendere l’arte.
Le
Avanguardie sono sempre state una forma di ribellione contro la
politica, il potere e la società.
L’arte
è stata usata come arama ed ha quasi sempre funzionato come tale.
Le
Avanguardie e l’ arte che c’è in esse sono quindi un metodo
rivoluzionario per ribellarsi.
Credo
che se oggi le Avanguardie storiche venissero riproposte nella
società per ribellarsi e rivoluzionare non tutti ne capirebbero il
senso. L’arte e tutto ciò che la riguarda viene ormai concepita
come “qualcosa di carino da vedere”, ciò richiama l’ assioma
di Andy Warhol “All is pretty” del 1968.
La
società sta diventando sempre più superficiale e non fa il minimo
sforzo per comprendere.
Le
Avanguardie e la loro importanza verrebbero sicuramente sottovalutate
o adirittura non considerate affatto a mio parere.
L’Avanguardia
che più mi interessa è il Dadaismo.
Il
Dadaismo è un movimento che nasce a Zurigo, in Svizzera, durante la
prima guerra Mondiale. Questa Avanguardia ha come principi
fondamentali prendersi gioco degli altri, provocare e andare contro
ogni logica.
Il
Dadaismo si ribellava contro ciò che è normale, ma lo faceva con
umorismo e sarcasmo. Ed è per questo che gli artisti che seguivano
questo movimento erano rispettosi e strani.
Il
Dada era quindi alla ricerca della libertà della fantasia.
Si
possono ritrovare questi aspetti nella poesia di Tristan Tzarà.
Nella poesia “per fare una poesia dadaista” l’ autore scrive
infatti che per fare una poesia bisogna semplicemente ritagliare le
parole da un giornale, porle in un sacchetto e mischiarle per poi
ricomporle in ordine casuale.
A
quel punto avremo ottenuto una poesia che rispecchia il nostro animo.
Il
poeta in questa poesia vuole provocare; lo fa però in modo pacato,
scherzoso ed ironico.
Usa
termini non troppo complicati per far capire bene il significato
della sua provocazione.
La
sua intenzione è porsi contro ai poeti; perché solitamente un poeta
mette nella propria poesia i suoi sentimenti e le sue riflessioni
avendo cura del modo in cui si esprime.
Tristan
Tzarà al contrario descrive la poesia come un processo quasi
meccanico, robotico e non calcolato, ovvero l’esatto opposto di ciò
che dovrebbe essere.
I
dadaisti non solo si dedicano alla poesia come scrittura, ma anche
all’arte visiva, usando materiali mai usati prima.
L’opera
di Duchamp chiamata “La Fontana” infatti vuole prendere in giro
la scultura e l’arte.
Quest’opera
non è altro che un urinatoio rovesciato con su scritto “Fontana”.
Se a quell’epoca avessimo messo un ricco borghese davanti ad un
opera del genere sarebbe probabilmente inorridito, o non la avrebbe
considerata con serietà.
I
Dadaisti usano quindi materiali molto comuni, quasi scontati.
L’arte
perde il suo significato, l’opera è un oggetto e basta, che non
propone alcun valore simbolico.
Tommaso
Rivella
Se
si provasse a proporre il concetto di avanguardia nella società
odierna, risulterebbe difficile che tale concetto catturi
l'attenzione e stupisca qualcuno. Il motivo sarebbe dato dal fatto
che la società è ormai sempre più disposta ad accettare e
assorbire ciò che è nuovo, la maggior parte delle volte,con totale
indifferenza.
Ormai,
grazie sopratutto ad internet e ai vari metodi di informazione
moderni, la gente è in grado di conoscere ed entrare in contatto con
ogni tipo di innovazione, ideologia ecc... e di conoscerne quasi ogni
aspetto. Di conseguenza, come già detto in precedenza, è difficile
riuscire a stupire una persona scuotendone la mente e mettendo in
crisi i suoi principi.
Ciò
non vuol dire che non esistano o non si possano creare avanguardie,
per esempio, una che mi viene in mente è la così detta “street
art”, la quale, si presenta in varie tipologie. Una di queste è
l'arte dei graffiti, che è una di quelle che stanno prendendo più
piede ultimamente. Severamente vietata nella maggior parte dei paesi
per via del fatto che viene espressa su muri, vagoni, ovunque insomma
e, di conseguenza, la ricca, buona e corretta società moderna non è
disposta a tollerarla e ritiene i writers dei delinquenti da fermare.
Tuttavia
anche questo tipo di avanguardia sta via via per essere assorbita dal
sistema, venendo publicizzata ed esposta come normali quadri in una
mostra. Specialmente negli ultimi tempi , nei quali questo fenomeno
si sta diffondendo sempre più, alcuni di questi artisti stanno
combattendo: cancellando, come è successo a Bologna, le proprie
opere in modo che nessuno le possa usarle per scopi per i quali non
sono state fatte.
Un'altro
metodo che potrebbe essere utilizzato per opporsi all'omologazione
nella società contemporanea potrebbe essere, semplicemente, l'essere
seri: è vero, può sembrare banale ma, pensandoci bene, se si guarda
la società dei consumi di adesso, questa tende a presentarsi come
una società allegra, piena di gioie e soddisfazioni, dove i problemi
non esistono e la gente si compiace di questa sensazione e vi si
adegua senza ragione diventando tutti burattini del potere.
Se
invece si analizza seriamente quello che ci circonda, si può
strappare questa maschera alla società e riuscire a contrastarla,
con una reale coscienza del motivo per cui lo si fa. L'andare
controcorrente non consiste semplicemente nel modo in cui ci
vestiamo o dal tipo di musica che si ascolta, ma anche da come la
nostra testa ragiona e da come noi ci comportiamo.
Tra
le avanguardie del secolo scorso, una mi ha particolarmente
interessato, ossia il dadaismo.
Mi
ha colpito sopratutto per il suo modo di rifiutare gli standard
artistici, e non solo tramite opere che andavano contro il modo
consueto di intendere l'arte stessa e la sua funzione nella società
novecentesca, ma anche mettendo in dubbio e stravolgendo ogni tipo di
convenzione sociale, enfatizzando la stravaganza e l'umorismo
passando attraverso i vari campi artistici fino a chiamare in causa
le ideologie politiche. Seguendo questo concetto, a mio parere si
potrebbe tutt'oggi conseguire la libertà creativa ed intellettuale,
riuscendo così a non essere burattini del potere.